La realtà va oltre la superficie. “I fatti” in una ballata blues
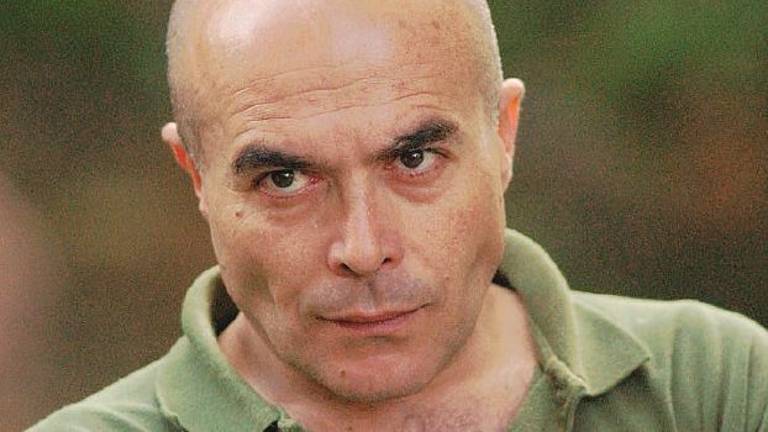
Era un anno che mancava dalle scene. L’emozione è sempre la stessa dei suoi vent’anni, quando ha iniziato?
«Peggio».
Addirittura.
«Hai più coscienza di tutto quello che devi fare per arrivare in fondo. Ma se muore quell’emozione lì vuol dire che è ora di cambiare mestiere. E forse anche di vivere».
“I Fatti” è composto da tre spettacoli precedenti che vengono legati da narrazioni nuove.
«Sì. Se vuoi le percentuali, saremo sul 35% di cose vecchie».
Come mai ha sentito il bisogno di tornare su cose che ha già raccontato?
«La mia ossessione per la palude, il metano, l’Anic, non è solo un fatto nostalgico. È un modo di guardare alla modernità. Questo tento di fare nello spettacolo. Parto da un dato biografico, la morte del fratello di mio nonno durante la Prima Guerra Mondiale. Qui parte l’onda della modernità – un’onda che è appena iniziata».
Lì è cambiato tutto?
«Sì, secondo tanti storici è così. La rivoluzione industriale è nata prima, lo sappiamo. Ma visto retrospettivamente, non sembra un caso che proprio allora siano scoppiate le guerre mondiali, i massacri industriali per eccellenza».
Nel monologo la guerra sembra collegata al disagio che provava da giovane, a Porto Corsini.
«Da giovane ero incazzato con tutti. Con la scuola, con gli adulti, con le istituzioni. Col mondo. Ero un contadino spaesato in un paese di operai. Dopo la guerra la mia famiglia contadina, da Imola, cercò lavoro a Ravenna, all’Anic. Anche questo significa essere testimoni della storia, subirla. Tutte queste cose, che avevo già trattato in altre narrazioni, sono tornate. Dovevo aggiungere una tappa. Non so se è quella definitiva. Forse il lavoro del narratore non finisce mai».
Come ha integrato i testi più vecchi alla nuova narrazione?
«Quelli del Volo, sulla Mecnavi, li ho spesso tagliati. L’Anic la racconto in Narrazione della pianura, scritta nel ’95. Lì non ho cambiato granché: sono pezzi più orali, che posso allungare o accorciare anche di 5 minuti. Il frammento sul bombardamento dei carri bestiame nella stazione di Imola viene da Al placido Don, del 2001, che ho scritto assieme a Renata Molinari. È molto letterario, e quello rimane così. Difficile rimaneggiarlo».
A legare questi tre cuori ci sono i nuovi racconti, spesso tratti dalla sua vita onirica. Peculiare che il sogno abbia una parte così importante in uno spettacolo che si chiama, pragmaticamente, “I fatti”.
«È tutto lì il rovello di questi mesi. L’ispirazione viene da un romanzo di Philip Roth. A un certo punto, dopo aver confuso la sua vita a forza di alter ego, si risolve a scrivere un romanzo di fatti: si stava perdendo. Ma poi penso anche a Simone Weil, quando dice che la verità non può esaurirsi nei fatti, e che nella realtà, “nel rumore delle foglie dei pioppi”, c’è qualcosa di più, che la eccede. Un monito. Ecco: bisogna guardare alla realtà sapendo che dice qualcosa che va oltre la superficie».
Come è iniziata la scrittura di queste nuove parti oniriche?
«Ho sfruttato il tempo lungo della malattia. Le ho scritte solamente quando scendevano. In genere, quando scrivo, mi prende l’ansia di arrivare in fondo; questa volta le ho lasciate andare. Per tanti anni ho pensato di non ricordare i sogni. Poi mi sono accorto che me li ricordavo eccome, ed erano diventati dei pezzi di vita. Il racconto del viaggio notturno sul Candiano: chissà da quanto tempo lo sogno. Non lo so. Poi se ne sono aggiunti altri, sempre precisi e ricorrenti».
Si è mai chiesto perché a un certo punto, come il metano delle paludi, sono venuti a galla?
«Non lo so. Forse coincide col tempo della malattia. Qualcosa non ti fa funzionare come al solito, e devi trovare un equilibrio. Quando sei bloccato devi ascoltare la tua interiorità. Chiaro che la mia non è un’interiorità di un letterato, ma quella di un teatrante, di un contadino e di un operaio dell’Anic. Qualcosa mi tiene agganciato qui. Forse sono proprio questi sogni».
La figura del griot, il poeta-narratore tribale della tradizione africana, è da sempre al centro dei suoi interessi. Cos’ha imparato dai griot?
«Nelle società tradizionali non esci mai dai ruoli. Il mondo occidentale non sopporta questa imposizione, noi i ruoli li abbiamo infranti da tempo. Ma avere un ruolo significa assumersi una responsabilità. Sei il narratore di una tribù? Fino alla fine ti tocca parlare di essa. Mi sono preso questa responsabilità e la porto avanti. Raccontare un’idea di Romagna, come ce ne sono tante: pensa a Cevoli, Marescotti, Giacobazzi. Ma perché nessuno parla di fabbrica? Della Mecnavi? Assumersi un’identità etnica significa prendersi una responsabilità. E io sento la responsabilità di raccontare queste storie. Sento che le devo raccontare per forza».
Come ha lavorato con Francesco Giampaoli?
«Io e Checco siamo molto simili. L’ho conosciuto una ventina di anni fa. Abbiamo sempre parlato pochissimo. Alcune cose della sua vita le sto scoprendo adesso. Siamo gente di valle entrambi, poco brillanti nella conversazione, nelle chiacchiere del centro. Amo questo modo di lavorare, la sua musica conquistata metro dopo metro. Gli ho consegnato il testo due mesi fa. Ha scritto la musica e ci siamo trovati per provare. E siamo partiti».
A proposito di romagnolità, nello spettacolo cita un bellissimo passo di Renato Serra che parla della stanzialità dei romagnoli.
«Da giovane ho conosciuto una signora del borgo San Biagio che non andava in piazza del Popolo da 25 anni. “Se un giorno ne avrò bisogno, ci andrò”, diceva. Era inconcepibile e meraviglioso. Credo che questo radicamento in Romagna sia molto più presente rispetto ad altre regioni. Non so perché. I miei parenti di Imola, ancora quando avevo 10 anni, non erano mai venuti al mare. Ma forse il pezzo di Serra vale per tutto il mondo».
Cos’è un narratore oggi?
«Come dice Benjamin, oggi il narratore è morto perché non va più nelle terre sconosciute per riportare un racconto. Oggi per stare in vita deve tenere le orecchie e i sensi più aperti possibile. Io voglio contaminare i miei ascoltatori e incuriosirli con queste storie».